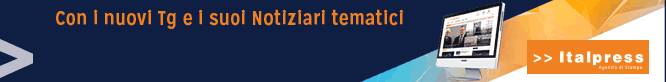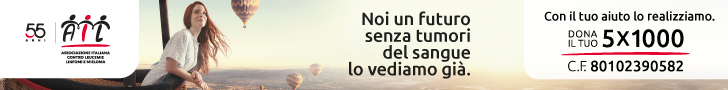Intervista esclusiva al presidente Roberto Rossini
 Roberto Rossini, presidente delle Acli
Roberto Rossini, presidente delle Acli di Dario Tiengo
ROMA. «Il pensiero collettivo è la forza delle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), un pensiero che nasce dalla nostra capacità di stare nella quotidianità della vita». Queste le prime parole pronunciate da Roberto Rossini al momento della sua elezione a presidente, avvenuta nel maggio 2016, con l’84,7% dei consensi dei delegati.
Il suo programma è improntato al «rilancio dell’azione quotidiana e volontaria, politicità dei servizi, formazione e dimensione culturale, azione pubblica». Nato nel 1964, vive a Brescia, è sposato e ha due figlie. Laureato in Scienze Politiche, è docente di Sociologia presso l’Istituto Maddalena di Canossa. Lo abbiamo incontrato a un recente convegno sul lavoro 4.0 tenutosi a Roma.
Recentemente è scomparso Giovanni Bianchi, una delle figure di maggior spicco delle Acli. Come lo ricorda?
Giovanni Bianchi per noi è stato decisivo. Ha ridato cittadinanza al cattolicesimo democratico, innervando così la nostra politicità. Ha dato un esempio splendido di fede matura. Ha ridato determinazione al movimento partendo dalla società civile, per trovare il nuovo luogo di ripresa dell’iniziativa dei lavoratori. Si trattava di trovare nuova linfa nel sociale e nel politico, in un movimento che nasceva dal basso.
Un fermento sociale fatto da molti protagonisti…
Esatto. La società civile, il terzo settore, il volontariato, il movimento cooperativo cioè tutta l’area che semplicemente chiamiamo “terzo settore” e che a quei tempi rappresentava un fermento sociale molto forte. Quindi se prima le radici delle Acli avevano trovato la loro origine sociale nell’operaismo, si trattava di trovare la propria origine sociale non solo nella classe operaia, che negli anni Ottanta era politicamente in crisi.
C’era ancora, però…
Anche oggi c’è la classe operaia. Gli operai ci sono ancora. Bisogna vedere se esprimono un’istanza sociale forte, se c’è un movimento che li rappresenta.
Oggi le Acli cosa sono?
Le Acli sono un “portale popolare”. Ci occupiamo delle istanze dei lavoratori, del terzo settore, dei più poveri, del cosiddetto ceto popolare. Quello che lavora, che fa fatica di arrivare a fine mese e ha bisogno di essere assistito. Offriamo servizi e cerchiamo anche di compiere la nostra opera di formatori di persone interessate al sociale e al politico, di portare avanti qualche buona battaglia.
Che tipo di battaglie?
Alcuni esempi sono il reddito di inclusione, lo ius soli, gli interventi sul tema delle pensioni e della riforma fiscale, le politiche attive del lavoro… cioè cerchiamo di sostenere le politiche che danno pari opportunità a tutti
Centrosinistra, Centrodestra o Centro?
Abbiamo uno slogan coniato nel tempo: “siamo autonomamente schierati”. Significa che siamo autonomi e non ci riconosciamo in nessun partito. Non dobbiamo rendere conto ad alcun partito. Una volta le Acli era in qualche misura una cinghia di trasmissione della Dc.
Negli anni Settanta non lo sono state molto…
Infatti al congresso di Torino del 1969 il movimento decise di non essere più collaterale ad alcun partito. E’ una scelta che vive ancora oggi. Non siamo collaterali ad alcun partito, non vogliamo esserlo. Però sui temi ci schieriamo. Ci siamo schierati sul tema dello ius soli, sul referendum costituzionale, sul tema della povertà, sulla 328, sulla riforma del terzo settore…
Che cosa pensa della politica e dei politici?
Credo che oggi la politica debba essere riscoperta come luogo nel quale si fa sintesi dei cambiamenti. Il mondo del lavoro è in continua trasformazione. Gli esperti dell’industria 4.0 ci stanno dicendo che nel giro di dieci anni cambierà completamente il quadro. Noi abbiamo bisogno di una politica che faccia sintesi e che reagisca. Siamo convinti che la politica possa farlo e quindi ne diamo un’interpretazione positiva. Crediamo che sia necessaria e importante ancora oggi. Per un cristiano, poi, la politica è quasi un obbligo o comunque un dovere morale.
Praticamente si ritorna a Sturzo e Dossetti?
Sturzo, Dossetti e Moro. Per noi rimangono dei fari. Giovanni Bianchi in uno dei suoi scritti più famosi diceva, negli anni Ottanta, che dopo Moro si doveva ritornare a Sturzo. Per dire che dobbiamo scoprire l’eredità del popolarismo, la tensione alla società civile che si organizza e che riesce a esprimere delle istanze politiche. Credo che oggi l’insegnamento di Sturzo sia ancora valido.
Quanti iscritti avete?
Tanti, tanti. Solo l’associazione madre ne ha 300mila; ma se si mettono insieme tutte le associazioni che sono vicine a noi arriviamo al milione di iscritti. Senza contare quelli che non prendono la tessera ma che utilizzano le Acli per una pratica, per un servizio, per una qualche utilità. E sono milioni.
Andiamo un po’ più a fondo. Quanto sente presente o assente il senso religioso nella nostra vita? Ci sono tendenze della politica e nella società che vanno all’esclusione e non all’inclusione, e la solidarietà è passata in secondo piano. La crisi ha messo in evidenza gli egoismi. Che ne pensa?
Ogni crisi porta con sé delle disperazioni e quindi è chiaro che può venire meno il legame solidale. In qualche misura diventa più difficile parlare di solidarietà ma, per certi aspetti, ci sono anche segnali positivi. Lo vediamo nella cooperazione, addirittura in alcune imprese che contrariamente a quanto sembrava hanno provato a fare progetti per uscire dalla crisi. Crediamo che la solidarietà possa essere uno strumento. Certo ci troviamo anche in una situazione molto complicata dal punto di vista della disponibilità economica e finanziaria. Oggi non è facile far quadrare i conti, perché il peso del debito qualcuno lo deve pur sostenere. Quindi è chiaro che possono esserci delle reazioni poco solidali o addirittura dei cambiamenti di organizzazione e di rotta.
Che cosa pensa a questo proposito del dibattito sui migranti?
Il dibattito sui migranti va avanti dagli anni Novanta. Se penso alla legge Martelli, sono passati quasi trent’anni e continuiamo a parlare dell’immigrazione come emergenza e problema. E’ vero che dal punto di vista quantitativo i numeri sono molto aumentati, però è anche vero che la politica dopo venticinque anni non è riuscita a fare sintesi e a trovare una via comune di uscita che sia condivisa dai partiti politici. Bisognerebbe mettere in campo alcune cose di buon senso per fronteggiare il fenomeno.
Quali ad esempio?
Lo iussoli sembrava una strada semplice da seguire per far in modo che questi ragazzini possano vivere e crescere in Italia dove già ci sono. L’altra questione che l’esperienza suggerisce è che, nel caso di profughi e rifugiati, la diffusione in piccolissimi gruppi nei territori e nei comuni è un sistema che non crea allarme e in alcuni casi ha stimolato la solidarietà sociale, è l’approccio degli Sprar. Se la politica gestisce questi fenomeni in modo condiviso, allora crea quelle condizioni affinché ci siano regole comuni: ad esempio il tema della lingua o il tema dei diritti delle donne potrebbero essere facilmente condivisi e rappresentare un patrimonio comune. Mi sembra strano che in venticinque anni non si sia arrivati a una determinazione.
La ricerca dell’asse verticale, la spiritualità, Dio – o comunque una dimensione fuori da sé – perché può essere decisiva in questo momento?
Credo che in questa fase sia importante dare anche una lettura spirituale. Giorgio La Pira diceva una cosa molto interessante: che bisognerebbe avere la capacità di leggere per ogni questione materiale una questione spirituale, cogliere cosa c’è di più essenziale nascosto anche nelle questioni materiali. Credo che questo sia un metodo che ancora oggi valga la pena di applicare. Oltre ai problemi materiali c’è anche un problema di spiritualità. La gente ha bisogno di valori, cerca dei valori e cerca di vedere oltre quello che si vede. A volte anche oltre la disperazione. Banalmente mi verrebbe da dire che vedo che moltissimi festival della filosofia avere molto successo. La gente legge, cerca, ascolta quelli che possono proporre un’ipotesi di senso. Questo significa che questa è una società che sta cercando di capire qual è il senso delle cose. La spiritualità è una grande forza.
Per ultimo, perché iscriversi alle Acli?
Ci si iscrive alle Acli prima di tutto perché si fa parte del popolo dei lavoratori. Una volta si potevano iscrivere solo gli operai. Adesso da molti anni abbiamo tantissime partite iva. Le Acli sono state sempre un’esperienza di lavoratori che pensavano di poter cambiare questo Paese attraverso il lavoro, con attenzione anche ai valori spirituali.
Cambiare il Paese, quindi fare politica?
C’è un aspetto di impegno dei lavoratori ma anche di un interesse dei lavoratori alla cosa pubblica. Spesso ragioniamo di politica e, siccome non abbiamo scadenze elettorali, siamo liberi e aperti. Siamo un luogo dove i lavoratori cercano di parlare di politica, pregare insieme e fare anche tante altre attività concrete al servizio del loro territorio. I circoli Acli a volte hanno il bar, a volte fanno volontariato, a volte fanno le pratiche di pensione, oppure organizzano gite. Sono, comunque, strumenti di coesione sociale; tengono insieme le persone che lavorano.
(Intervista esclusiva in collaborazione con tibunapoliticaweb.it)