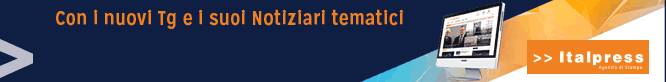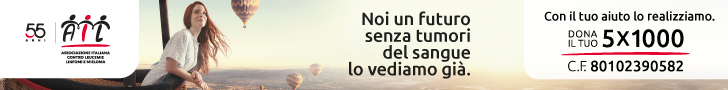di Giulia Tacchetti
SIENA. Oggi (13 aprile) è stato inaugurata la sede dell’Archivio storico dell’Opera, terminati i lavori di ristrutturazione interna dei locali che lo ospitano in via Monna Agnese al n.13. Interessante la breve lezione del prof. Stefano Moscadelli, che in accordo con l’Istituto Tedesco di Storia dell’Arte ha curato un inventario del fondo archivistico “L’Archivio dell’Opera della Metropolitana di Siena: inventario, Munchen, Bruckmann, 1995”. Il suo intervento parte dal significato del termine “archivio”, inteso come sedimento documentario di una attività, in questo caso dell’Opa, in un arco di 1000 anni circa, conservato in un luogo. L’archivio è lo specchio di quello che è stata l’Opa, il modo in cui l’istituzione ha curato la propria memoria, la propria identità. Conserva i più antichi documenti storici ed artistici riguardanti la costruzione della Cattedrale ed il suo corredo decorativo, che oggi costituiscono il patrimonio museale del Duomo di Siena. Per questo è di fondamentale importanza per la ricostruzione artistico-architettonica della città. Opa, abbreviazione archivistica del termine opera, dal Latino opus-eris, significa cantiere. Tante altre opere erano in Siena, quella del Comune o di un importante palazzo, da qui nasce il termine operaio. Quando il cantiere diventa istituzione ha bisogno di un operaio, cioè di un presidente. Tra il 1250-60 viene individuato il momento in cui Il cantiere dell’Opa è regolarizzato, ha una sua autonomia, ha un patrimonio e viene sottoposto a controlli burocratici e fiscali, anche da parte del Comune, perciò diventa una istituzione e quindi serve un archivio. L’attività contabile è la più rilevante per tutto il basso Medio Evo, quando è in corso la costruzione della cattedrale, fino al Duomo Nuovo, con l’aiuto di finanziamenti. Le entrate, oltre che dai lasciti e dalle eredità, provengono soprattutto dalla commercializzazione della cera. Il giorno dell’Assunta (15 agosto) cittadini, signori, contadini devono recare in cattedrale la cera, come offerta alla Vergine.
La visita al nuovo allestimento, che occupa l’ultimo piano del palazzo, diviso a sua volta in due sezioni attraverso una comoda scala, dai documenti più antichi (risalenti all’XI sec.) a quelli dei nostri giorni (di questa ultima parte si è occupata la dott.ssa Fabbrini) inizia con una bacheca in cui sono conservate le pergamene più antiche ed un corale miniato da Sano di Pietro del XV sec.. Notevole è la pergamena datata 1085, un atto notarile di epoca longobarda, con cui il vescovo rinuncia ad ogni controllo sul castello di Monteroni. Seguono scritture autografe relative ad interventi scultorei ed architettonici di artisti come Donatello e Ghiberti; un “Libro di entrata e uscita” relativo agli anni 1339-40, con riferimenti alle spese sostenute per la costruzione del Duomo Nuovo; un fondo musicale, costituito da una notevole quantità di partiture di musica sacra.
Si capisce quanto il luogo si presti a future visite didattiche delle scolaresche, sia per la sua valenza artistica locale sia per quella di Storia Medievale, ma anche quanto interesse possa rivestire nei confronti di turisti italiani e stranieri.