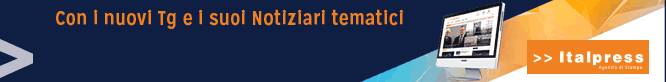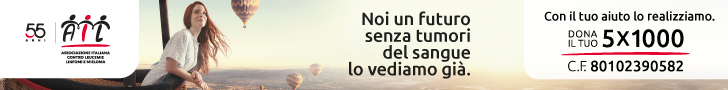L'arte come consapevolezza del nostro patrimonio e coscienza critica
 Tomaso Montanari
Tomaso Montanari di Giulia Tacchetti
SIENA. Criticare i programmi e la funzione della TV è all’ordine del giorno: basti notare l’attenzione mediatica a livello ossessivo dedicata al Festival di Sanremo, conclusosi da pochi giorni.
Ma ogni tanto balza all’attenzione del grande pubblico una trasmissione di qualità, che porta dentro le case degli Italiani la cultura attraverso la voce e la presenza di uno studioso relativamente giovane (classe 1971). Si tratta di uno storico dell’arte, Tomaso Montanari, professore ordinario all’Università di Napoli “Federico II”, giornalista e blogger, che attualmente presenta su Rai 5 in 12 puntate “ La vera natura di Caravaggio”. Nel 2015 ha presentato sempre sulla stessa rete “La libertà di Bernini” in 8 puntate.
Il numeroso pubblico accorso ieri (16 febbraio) in un’aula dell’Università di Siena è rimasto incollato alla sedia fino alle ore 20, tanto da obbligare l’organizzatrice dell’incontro, Gabriella Piccinni, a concluderlo vista l’ora tarda e la generosità con cui Montanari ha risposto alle domande degli spettatori. Indubbiamente molti dei presenti lo hanno conosciuto grazie al suo impegno divulgativo dell’arte con le trasmissioni su Rai 5, che non sono semplici documentari, ma introducono “i non addetti ai lavori” alla indagine minuziosa di un artista (particolarmente del 1600) non solo attraverso l’analisi delle sue opere, ma anche attraverso la lettura in diretta di tutti i tipi di documenti in possesso: dalle lettere pervenute, alle storie delle vite raccontate, ai pagamenti delle opere commissionate; il che denota una pratica, a volte abbandonata, degli archivi, oltre che una profonda conoscenza dei testi bibliografici, italiani e stranieri.
Ieri Montanari si è presentato in un’aula dell’Università di Siena per far conoscere il suo ultimo libro “La libertà di Bernini” (Einaudi 2016); dopo i convenevoli, il professor Angelini che chiede all’autore se il suo saggio vuole dimostrare una tesi, provocando il ribaltamento di certi tόπoi (tòpoi) sulla storiografia del Bernini, come la diffusa convinzione di un artista organico al volere della Chiesa. Dal saggio emerge una figura complessa, che vive anche con drammaticità, pur non opponendosi alla Chiesa, rappresentata dal papa Urbano VIII. Non esce un Bernini opposto a quello degli studi precedenti: ha avuto potere e ricchezza, è stato dittatore della scena artistica romana, ha vissuto a lungo.
Il saggio è un tentativo di dare un ordine a tante domande, ad un senso di contraddizione che nasce leggendo e studiando tutto ciò che ci rimane dell’artista, che testimonia un rapporto non sempre idilliaco tra questi ed il papa. Bernini ha scritto un testo teatrale che nasconde la sua biografia. Ne esce un personaggio complesso “bisogna fare i conti con l’immagine che lui stesso ha ordito di sé”. Nella storiografia acritica i mecenati sono presentati come i benefattori dell’arte. Dopo l’incontro con Urbano VIII, che pure lo renderà grande artista, non scolpirà più i temi profani. L’episodio raccontato da Bernini vecchio, sulla censura di un cardinale d’oltralpe sul decoro di Apollo e Dafne, che l’autore considerava un capolavoro, dimostra che comunque c’è un attrito con il potere ufficiale. Non c’è una eresia nel suo ruolo di artista, solo si prende il suo spazio, almeno sull’immagine del decoro. Infatti dopo Apollo e Dafne passa da poeta profano a poeta sacro, affermando la sua libertà sulle regole del potere, non certo sui contenuti alla maniera di Caravaggio. Ribadisce la sovranità degli artisti nella ritrattistica teorizzando il bello ideale nei suoi busti. Così il grande artista conquista il suo spazio stando dentro le regole. Questa sofferenza dell’anima ce la comunica un Bernini ormai vecchio, che sente di palesare conflitti ormai passati e noi li sappiamo perché ne parla lui stesso e le sue parole coincidono con quelle usate nelle lettere dei testimoni oculari, dei biografi (ossequiosa repulsa). Un suo giudizio sui committenti è evidente nelle caricature, in cui si ribadisce la sovranità degli artisti.
Montanari affronta non una monografia, ci tiene a precisare, ma, anche attraverso l’uso della televisione, mira a creare una consapevolezza civile del nostro patrimonio artistico, una coscienza critica. Il libro vuole essere un saggio scientifico, scritto però in modo da potere essere accessibile ad un pubblico vasto, rivolgendosi anche agli altri umanisti, in quanto “abbiamo smesso di leggerci, lontani nelle ricerche reciproche, storici, critici dell’arte”.