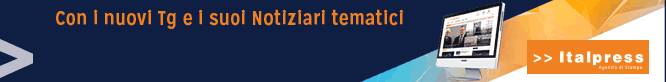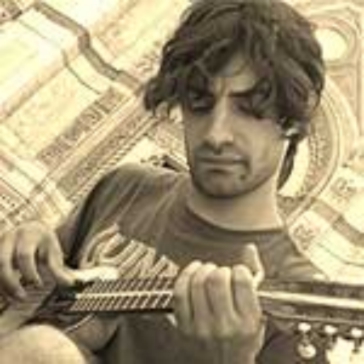
Con le sue cinque corde doppie e la caratteristica tessitura alta, il timbro del charango boliviano risulta particolarmente vicino a quello del liuto rinascimentale. Tale somiglianza pone oggi questo strumento al centro di una grande attività di trascrizione di musica antica e barocca. Al concerto ascolteremo una raccolta di pezzi antichi di A. Vivaldi e tarantelle della tradizione siciliana e brani di R. Calce, arrangiati e interpretati dal giovane compositore. Michel Barros Bessone nasce a Santiago del Cile, da una famiglia di musicisti. Inizia a suonare il flauto quando aveva nove anni, tre anni dopo scopre la chitarra, che col tempo diventa lo strumento principale del suo mestiere, insieme a tutti gli strumenti a corde. Vanta varie esperienze quale compositore per TV, teatro, danza moderna, rock band, cortometraggi e altri lavori audiovisivi. Dirige diversi gruppi musicali, nell'ambito della musica classica, folk e rock.
Per informazioni contattare l’ Ufficio Cultura Comune di Siena – O577.292225 – cultura_teatri@comune.siena.it per le prenotazioni Segreteria FCB – 329 5659053. INFO – info@fcbs.it www.fcbs.it
Programma musicale:
A. VIVALDI (1678-1741) / Concerto op. 3 n. 8 RV522 (trascr. Per charango)
Allegro, Larghetto e spiritoso, Allegro
Tarantella (tradizionale Sicilia)
'ntunazione (tradizionale Sicilia)
Tarantella bizantina (tradizionale Sicilia)
Tarantella dell’800 (tradizionale Puglia, trascr. Xanti Yaca)
///
RAFFAELE CALACE (1863-1934) / Danza Spagnola
Tarantella montemaranese (tradizionale Campania)
Tarantella (tradizionale Sicilia)
Tarantella del ’600 (tradizionale)
Tarantella napoletana (tradizionale)
MICHEL BARROS BESSONE / Al vuelito del zorzal
Scheda di approfondimento
Quando i Conquistadores invasero le Ande, oltre al terribile carico di morte, avevano probabilmente portato con sé le musiche di Antonio Mudarra (1510-1580), grande suonatore di vihuela e il primo autore di cui ci siano pervenute composizioni per chitarra. Chissà in quali occasioni gli indios abbiano potuto ascoltarle. Di sicuro l’incontro fra la cultura musicale dei conquistatori spagnoli e quella dei popoli andini ha portato alla nascita del charango, uno strumento ibrido che imita la vihuela, ma usa come cassa armonica una corazza di un armadillo. Oggi in Bolivia e Perù il suo suono accompagna le serenate amorose e i gesti del corteggiamento. Così, seguendo il modello culturale tipico della creolizzazione, l’esempio musicale colto della corte spagnola è stato reinterpretato nell’idioma locale, facendo nascere i tratti di una nuova musica popolare. La stessa dinamica culturale, contemporaneamente ma da un’altra parte del mondo, ha coinvolto le tarantelle: musiche popolari nate dall’uso di bassi ostinati su cui improvvisare composizioni poetiche da rammentare, per costruire una tradizione. Le mitiche origini popolari cui i compositori barocchi facevano risalire queste forme di danza ritornano così al “popolo”, erede delle formulae musicali su cui nelle corti più di un virtuoso aveva improvvisato. Con le sue cinque corde doppie e la caratteristica tessitura alta, il timbro del charango boliviano risulta particolarmente vicino a quello del liuto rinascimentale. Tale somiglianza pone oggi questo strumento al centro di una grande attività di trascrizione di musica antica e barocca. In questo spirito ascoltiamo l’arrangiamento del Concerto in la minore di Vivaldi.
Il suono acuto delle corde doppie associa inconfondibilmente il charango boliviano anche al mandolino. Già presente nel Settecento come strumento solista nei concerti barocchi da Venezia a Napoli e in tutta Europa, è anch’esso uno strumento “nobile” che, con i recenti stereotipi della comunicazione di massa, è divenuto il simbolo della cultura popolare del meridione italiano. Dalle splendenti sale stuccate alla penombra affascinante delle botteghe dei barbieri. Sui sentieri del mandolino, Barros esegue al charango la Danza Spagnola di Calace.
Il percorso sul suono del meridione italiano prosegue con le tarantelle che, a partire dalla fine del Cinquecento, si diffusero in mille forme dalla Puglia meridionale fino in Sicilia, per narrare di santi che salvano miracolosamente da mali tragici e misteriosi. Ascoltandola a Capri nel 1907 durante il suo viaggio in Italia, R.M. Rilke scrisse della tarantella: "È come se fosse stata inventata da ninfe e satiri; antica, riscoperta e risorta, colma di atavici ricordi. Astuzia, selvatichezza, ebrietà: uomini che han zoccoli di caproni e fanciulle del corteggio di Artemide…”.
Parole che riecheggiano panorami già cari ai poeti di Arcadia più di due secoli prima.
(Stefano Jacoviello)