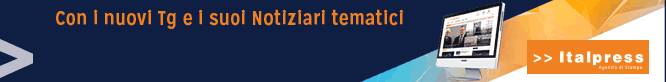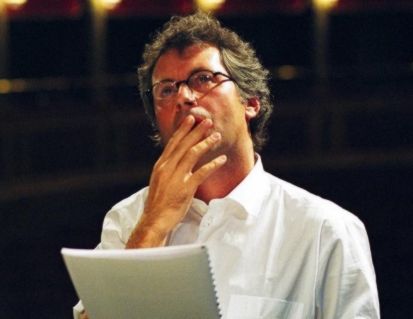
di Lorenzo Pini
SIENA. Chi di Baricco ha seguito la parabola non può che rimanere spiazzato dalla traiettoria di Emmaus, un libro avorio edito da Feltrinelli (novembre 2009, "I Narratori", pp. 139, € 13) con bandelle tutte bianche e una quarta di copertina di due righe e mezzo. C’è un nordovest italiano di periferia cittadina, si intuiscono canali dritti sotto a ponti bassi, semafori spenti, asfalti umidi e nebbie pomeridiane che appena appena si sollevano a mezzogiorno – lasciano un barlume di luce penetrare sui pioppi – poi si abbassano di nuovo sulle fabbriche dopo il tramonto.
Emmaus parla dell’esistenza di una generazione al culmine dell’adolescenza, presumibilmente quella del Baricco anni Settanta. Un romanzo costruito intorno al personaggio di Andre, ragazza dal temperamento di un pellerossa, libera e bella, dai capelli lunghi, appartenente a una famiglia moderna senza orari e con la servitù, e prostituta in occasioni mendaci. Mento e bocca che stregano, un’eleganza erudita che attraverso gesta libere (sessuali, spesso), sconvolge le tappe di vita di un gruppo di amici: Bobby, Il Santo, Luca, l’io narrante. Ragazzi di diciassette anni che fanno volontariato, suonano in Chiesa, vanno a Messa. Ligi ai doveri familiari e ai catechismi della loro parrocchia. Non fumano, non bevono, non fanno sesso. L’incontro con Andre cambierà la direzione delle loro vite. Da lì in poi, sarà un viaggio verso ciò che non avevano mai creduto possibile. Bobby, Luca e Il Santo si disintegreranno. A restare sarà la voce dell’io narrante.
Nella frattura tra i quattro ragazzi cattolici e la carismatica hippy sta l’energia necessaria di cui l’autore si serve per la narrazione. In questo Baricco segue una pista che la letteratura ha battuto assai da quando il romanzo psicologico ha scisso l’esperienza umana, individuando nella molteplicità delle esistenze il naturale riflesso della duplicità dell’io. Lo fa con una prima persona plurale sospesa nel tempo passato, che diffonde una aurea di immobilità al narrato. Succedono cose in una sequenza che è già irreversibile, che è già successa e procede piena come un lento macigno di fango verso valle. Chi parla esprime un tono sarcastico-misto-zelante nei confronti della religione. Con la voce di un uomo maturo che commenta i suoi anni giovanili, in cui, purtroppo, gli fu imposto di fare così.
Un romanzo esistenziale quindi questo Emmaus, che affonda le radici nelle viscere dell’educazione e dell’azione, dell’esperienza, della giovinezza come preambolo alla vita. Andre incarna la società moderna, quella “avanti”rispetto all’io narrante. Sullo sfondo, famiglie e adulti dagli ideali contrapposti, ma accomunati dall’inerzia che trasmettono ai propri figli.
Si tratta dell’effetto di una ragazza ribelle su una generazione di giovani immobili nelle loro vite di cattolici praticanti, integrati in una rete di coordinate al di fuori delle quali la loro vita tende a perdere di significato. A poco a poco, accade che ognuno dei protagonisti venga allontanato (o si allontani) da quella retta via percorsa nel solco dell’educazione, e vada incontro a folate di realtà rovesciate, rispetto alla percezione di sempre. Non si tratta di una fede “cristiana”, o cattolica che viene perduta. Si tratta di un radicale mutamento del punto di vista con cui si guarda la vita. Dio è solo l’atto finale che soddisfa una reazione alla società senza valori, ma l’impressione è che il suo nome possa essere sostituito. In Emmaus Baricco parla delle fede come una delle reazioni alla vita, e non come motivo di vita.
Frasi a effetto corredano il testo, frasi dal senso un po’ epico, un po’ solenne. In questo Baricco fa fede a un titolo criptico, mistico (suggestivo?), che altro non è che il nome di una cittadina presso Betlemme. Il significato del libro intero sta qui. A partire da una considerazione fisica: la parola “Emmaus” compare una sola volta nel romanzo, pressoché al centro del libro. Ne è quindi il contenuto unico e baricentro. La parola ricorre nel Vangelo e rappresenta un’epifania. Qualche giorno dopo la morte di Cristo infatti due uomini incontrano un tale sulla strada che conduce alla cittadina di Emmaus e gli raccontano della morte di Gesù a Gerusalemme rispondendo ad alcune sue domande. Lo invitano a cena e solo dopo molte ore si accorgono che stanno parlando con il Messia, che a quel punto sparisce. Fuor di metafora: nella vita tutto accade senza che ce ne accorgiamo. Perdiamo il presente, e a fatica catturiamo l’inizio e la fine. Ci è dato quel che ci è dato, ogni tanto alcuni eventi segnano l’esistenza e una mano stringe forte il volante dando una secca sterzata. Questa è Andre per i protagonisti di Emmaus. «Hai visto Andre?, mi chiese […]. Mi venne da rispondere Dovunque. Suonò un po’ esagerato, a dire il vero. Così aggiunsi Da lontano». Pagina novantanove. È ripetuto l’incipit del romanzo, in cui la voce narrante ripete un’altra parola-chiave. Sembra che solo da “lontano”, grazie a una necessaria distanza temporale, sia possibile percepire una verità, quella che lo stesso autore è in grado di mettere a fuoco solo molti anni dopo rispetto alle vicende che ha vissuto in adolescenza.
In alcuni scorci del libro, tra i particolari vividi, ora in un quadro erotico, ora brumoso fatalista, l’immagine trasmessa al lettore è quella di un passato ovattato malinconico, che però era bello, tanto bello, quasi da pentirsene, per l’ottusa stupidità con cui non era compreso. A ogni nascita corrisponde una morte. A ogni colpa un castigo. Baricco ha voluto addentrarsi nei meandri della condizione umana attraverso l’esperienza di una generazione, e l’ha fatto in questo libro caricando le vicende di un forte valore simbolico. L’uso delle metafore, massiccio, e a partire dal titolo, cruciale, è il modo con cui Baricco svolge il tema della sua scrittura. Alla fine, solo l’io narrante tornerà alla vita che conduceva prima di conoscere Andre. Tutti gli altri (Il Santo, Luca e Bobby), sceglieranno altre strade, anche tragiche. Eppure il ritorno non è una riconciliazione con se stessi ma una presa di coscienza che l’immobilità nascondeva un lungo viaggio. La droga, la morte, la galera, si affacciano come un naturale riflesso della volontà mesta e china rispetto al destino già scritto. E poi, qualche colpo di scena, illustrato con la solita pacatezza.
Un po’ paradossale è lo snocciolamento di eventi estremi con un’indifferenza camussiana, specie nella seconda metà del libro. Accadono cose che un’ostentata noncuranza e freddura non possono raccontare senza lasciare l’impressione di una forzatura. Sprazzi di espressionismo perentorio, che però non intaccano l’inerzia, vera sensazione dominante.
Tutto sommato, però, è un Baricco nuovo, a cui non si può negare l’audacia e la bravura nell’affrontare un tema così ampio come la percezione dell’esistenza. Stavolta, però, la sapienza formale del suo stile e lessico, finisce per essere un’arma a doppio taglio. Curiosamente, il doppio volto dell’esistenza che Baricco ci racconta, si ricrea alle sue spalle senza che lui se ne accorga. Se, infatti, l’apparente spontanea procedura stilistica, improntata sulla pacatezza e la pulizia del lessico, poteva calzare a pennello per i lettori di romanzi come Seta o Oceano Mare, appare in Emmaus persino artificiosa al confronto coi temi che vuol raccontare, come se quest’ultima fatica letteraria fosse per l’autore una strategia verso una personale nuova immagine, chissà secondo quale fede editoriale. Ad ogni modo, una scelta coraggiosa. Per questi motivi la prima cosa che viene da chiedersi è: che cosa è successo a Baricco?