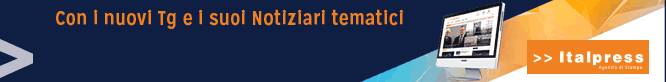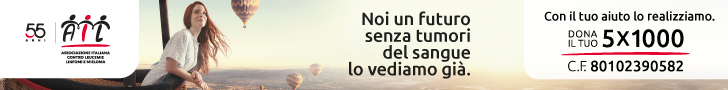Castri trova soluzioni sceniche che sottolineano lo straniamento

SIENA. E’ andato in scena al Teatro dei Rinnovati, sabato 24 novembre, “La cantatrice calva” di Eugène Ionesco con la regia di Massimo Castri, uno dei migliori registi italiani, premio UBU 2010 per “Finale di partita” di S. Beckett. Il regista ha proseguito la sua ricerca sul teatro dell’assurdo con l’allestimento di questa pièce teatrale, dalla durata di circa un’ora, prodotta dal Metastasio-Teatro Stabile della Toscana, avvalendosi della collaborazione di Marco Plini, della traduzione di Gian Renzo Morteo e di attori validi e di effetto nel ruolo di automi viventi, senza alcuna sostanza psicologica (V. Banci, M. Malinverno, F. Borchi, E.C. Langone, F. Mascagni, S. Zanobbio).
Nel teatro dell’assurdo viene innanzi tutto meno la logica dell’intreccio: l’azione è inesistente in quanto costituita da eventi slegati tra loro. Attraverso questa disarticolazione del tessuto drammatico e la conseguente distruzione di rappresentare il verosimile, Ionesco volge le spalle al teatro del realismo e psicologico; al teatro ben fatto, cioè strutturato in modo equilibrato ed a quello basato sulla parola, cioè sul dialogo. I personaggi, i coniugi Smith e Martin, la cameriera ed il capitano dei pompieri, si scambiano battute prive di senso (“si cammina con i piedi, ma ci si riscalda con l’elettricità”, “compro un coltello per mio fratello, ma tu non puoi comprare l’Irlanda per tua nonna”), in un crescendo di assurdità , come il ripetere in maniera ossessiva “non è di qua, ma è di là”, che cosa non è dato sapere, fino a giungere alle urla finali (suoni onomatopeici). L’effetto è quello di uno straniamento costante che il regista ottiene, attraverso anche l’uso di luci basse, puntando tutta l’attenzione sul dialogo privo di ogni logica. In uno scenario da interno borghese, dove tutto viene etichettato “inglese” dal cibo alle scarpe, è il dialogo che sancisce l’incomunicabilità all’interno di una classe sociale, la borghesia, i cui rappresentanti, i coniugi Smith e Martin, non agiscono, non esprimono sentimenti, sono prigionieri del conformismo ed appaiono come automi senza pensiero. Così Ionesco come Beckett denunciano l’assurdità del vivere, che genera l’angoscia del mondo contemporaneo. Il clima che il regista instaura con il pubblico, accorso numeroso e di tutte le età, è divertente. I presenti ridono all’incoerenza di certi aneddoti , come quando la signora Martin parla di un uomo incontrato per strada con un ginocchio a terra che…stava legandosi le scarpe ed i personaggi rispondono all’unisono: ”ma che fantasticooo!” . Le molte trovate comiche non impediscono all’opera di rappresentare l’infelicità umana. Il regista, quando afferma di vivere in una società in cui la piccola borghesia non esiste più come classe sociale distinta, la eleva ad archetipo della desolazione ed angoscia in cui vivono tutti gli uomini. Forse li salverà la cantatrice calva, aspettata invano dai presenti?