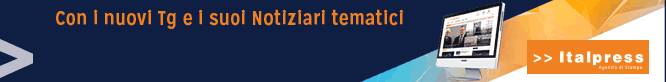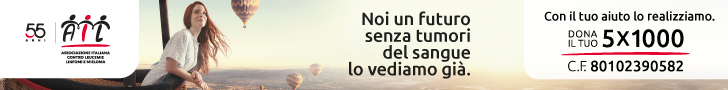A volte, non essere contemporaneo può voler dire essere innovativo...

SIENA. Vorrei fare delle considerazioni in merito all’uso dell’arte sacra in un contesto di culto come può essere una chiesa e in modo particolare di una chiesa come il Duomo di Siena. Considerazioni che a prima vista e con molta probabilità non saranno gradite ad alcuni operatori economici.
Abbiamo nel corso del tempo assistito ad una decontestualizzazione dell’opera d’arte di origine sacra. Molte di queste hanno subito il destino di altre di stampo laico: quello di essere musealizzate. Perdendo in questo modo il contesto del luogo per cui erano state fatte e pensate. In generale ogni opera d’arte vive per lo spazio e per la luce per cui è stata realizzata, ma in modo particolare quelle sacre. Il museo di tipo ottocentesco alinea le opere, le snatura. Per estremizzare: è come una esposizione commerciale fatta per perdere poco tempo, un colpo d’occhio e via, il visitatore ne esce confuso, tramortito dall’eccesso di illuminazione, privo di un concreto ricordo.
Immaginate voi una pala d’altare inserita in un museo, magari diocesano, insieme ad altre opere una dopo l’altra e tutte a sfondo religioso. Come può restare qualcosa di significativo in chi la guarda? Come può rimanere in vita un’opera che è stata pensata per la liturgia, che dovrebbe ricordare al fedele il divino, che si anima nel significato della Parola e al lume di qualche candela? Tutto questo sparisce a vantaggio del consumismo della visione, nella rapidità superficiale dell’immagine contemporanea che ha perduto il contenuto a vantaggio della semplice forma. Qualche tentativo, molto isolato, di percorrere antiche strade che risultano fortemente innovative si è tentato. È di qualche anno fa la riconsacrazione di tre icone russe nel battistero di Firenze, risistemate sull’altare a cui è stata ridata luce tramite delle candele appositamente realizzate (Florenskij). O come è pieno di spiritualità il trittico di Lorenzo Monaco a Firenze illuminato dalla luce del sole che vive nella dinamica del tempo meteorologico.
A questa stagione che poteva almeno avere degli aspetti positivi, come quello della conservazione, se ne è sostituita una, a mio parere, ancora più discutibile: le chiese sono diventate esse stesse dei musei. Hanno perso il loro carattere di luogo dedicato al culto per diventare ricettacolo di forme che si susseguono nella loro dimensione puramente estetica. Musei dove si paga un biglietto di ingresso, caro in alcuni casi. Dove se qualche fedele vuole entrare per pregare e ridare significato divino e contenuto spirituale all’opera sacra per non pagare, nei migliore dei casi e se è residente, deve mostrare la carta di identità. Come se fosse alla dogana o alla reception di un albergo. L’arte sacra è fatta per la contemplazione, richiede tempo, vive e rivive nel gesto liturgico, non vuole la luce retinica ma quella più calda del movimento delle candele. Quel movimento per cui erano stati realizzati gli angeli del Beccafumi o quelli dell’altare maggiore di Francesco di Giorgio Martini nel Duomo di Siena. L’arte sacra ha bisogno di tempo perché racchiude in sé gli elementi filosofici e teologici del periodo in cui è stata realizzata. Quel tempo che va contro la commercializzazione a cui sembrano essersi ormai abbandonati anche i responsabili del culto. Con quei consumatori che fanno la fila come se fossero in attesa di entrare in qualche supermercato con l’atteggiamento di chi incurante del luogo vuole stare a suo agio in comodi bermuda e in confortevoli sandali.
Vorrei che queste rapide considerazioni non fossero esaminate come tesi fuori tempo, convinto come sono che qualche volta e su alcuni argomenti non essere nel contemporaneo voglia dire essere innovativo e materia di vera considerazione. Voglia dire essere oggetto di una curiosità perduta, capaci di attirare l’attenzione di chi vuol veramente capire e si muove consapevolmente, che cerca la qualità e che magari vuole comprendere Siena per quell'”altra” storia dell’arte italiana che non passa ne’ per Firenze ne’ per Roma. Comprensione che richiede tempo e buone strutture ricettive che fanno del Santa Maria della Scala il centro dell’arte figurativa senese come ci ha lasciato in eredità Cesare Brandi.
Pierluigi Piccini
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabella normale”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}