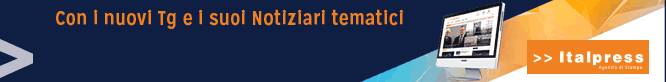SIENA. Sin da tempi remoti i senesi hanno avuto un gusto particolare per il gioco. A giudicare dai reperti archeologici giunti sino ai nostri tempi, già in epoca romana gli abitanti di Saena Julia (nome di fondazione latino della città), uno dei più importanti avamposti di Roma antica in territorio etrusco, dovevano intrattenersi con gli stessi passatempi in voga per le strade e le Tabernae Lusoriae dell’urbe. Retrobottega di locande ed osterie, ma anche case di privati dovevano infatti accogliere nugoli di appassionati di dadi, astragali, Navia aut capita (testa o croce), Ludus Latruncolorum (una sorta di dama d’antan che si giocava sulla tabula lusoria) e del duodecim scriptorum, un antesignano del moderno Backgammon, che, come suggerisce il latino, era giocato su dodici righe sempre con l’uso della tabula lusoria.
Dopo Roma, Siena è del resto la più “romana” delle città italiane e sono ampiamente noti i profondi legami che uniscono la città del Palio alla caput mundi a partire dalla lupa, presente in alcuni blasoni cittadini d’epoca medievale. Questo mammifero archetipo della nutrice è un richiamo alla leggenda dei gemelli Senio e Ascanio, figli di Remo che, fuggendo dall’Urbe a seguito del più celebre fratricidio della storia, decisero di gettare le fondamenta di Siena portando dalla capitale del nascente impero l’animale che pascé i divini fanciulli romulei.
Digressioni comparative a parte che potrebbero comprendere ad esempio anche l’intestazione medievale posta proprio sotto al piedistallo della lupa all’entrata di Porta San Lorenzo che cita SPQS (Senatus Popolusque Senensis), si può senza dubbio affermare che il gioco – e non solo quello da taberna – sia sempre stato amato e largamente praticato dai senesi di tutte le epoche. In particolare, Medioevo e Rinascimento hanno visto la città ospitare bufalate (corse di bufale disputate dalle contrade), asinate (corse di asini disputate dalle contrade), cacce dei tori (sorta di corride che si tenevano in Piazza del Campo), Giochi di San Giorgio o Juvenalia (simulazioni di guerra per bambini che si disputavano con corazze e spade di legno), Giochi dell’elmora (altro genere di battaglie combattute dalla plebe per finta), giochi della pugna (competizioni ludico militari combattute tra i giovani più valenti dei Terzi della città), battagliuole varie e persino pallonate (corrispettivo senese del calcio fiorentino).
Risulta così possibile affermare che la vita della città fosse scandita letteralmente da momenti di svago che tuttavia, per l’innata indole bellicosa dei senesi (almeno di quelli d’un tempo) si trasformavano molto spesso in occasioni per fare i conti e dopo qualche sgarbo, scorrettezza o parola di troppo, la festa tendeva spesso a degenerare e finiva anche per scapparci il morto. Questi spargimenti di sangue preoccupavano naturalmente le autorità comunali, che cercavano di tenere a bada, molto spesso senza grandi successi, i bollenti spiriti dei concittadini.
Soprattutto in epoca medievale e in virtù dell’attitudine belligerante del corpo cittadino, impegnato a costruirsi un proprio stato nella bassa Toscana (la cosiddetta respublica senensis), si tendeva del resto a chiudere un occhio. La convinzione di chi guidava lo Stato all’epoca era senz’altro quella che i lutti e l’asprezza dei confronti servissero a forgiare il carattere del nerbo dell’esercito senese, strumento indispensabile per l’espansione del potere di Siena al di fuori delle mura civiche. Nel tempo, quando gli eventi portarono la città sotto l’egemonia dei Medici, riducendo così le brame espansioniste dei senesi, che riuscirono soltanto a salvaguardare una larga autonomia amministrativa e magistrature proprie, queste attività al limite tra la resa dei conti e una guerra simulata diventarono inutili e vennero quasi tutte vietate. Sopravvissero il Palio alla Tonda (antesignano di quello moderno con le contrade) e quello rionale, mentre i giochi da Baratteria (i casinò dell’epoca), nonostante il fervore delle prediche di Bernardino da Siena, grande nemico degli svaghi da osteria, erano stati sempre più o meno accettati o, meglio, in più occasioni erano stati anche favoriti grazie alle ricche imposte sul gioco che spesso contribuivano in maniera consistente alle opere pubbliche e alla risanazione delle casse cittadine dissanguate dai costi della “guerra perenne”.

Oggi che la passione per il gioco si coltiva soprattutto nel web e attraverso alcuni dei maggiori portali, che offrono questo genere di servizi come casino online 888, è difficile immaginare un tempo in cui gli amanti di questo genere di svaghi, per soddisfare la loro voglia di divertimento fossero costretti a scendere in strada.
La Zara, che consisteva nell’azzeccare i numeri della combinazione di tre dadi (taxilli) lanciati su di un piano liscio (un tavolo o anche in terra), era uno degli intrattenimenti più diffusi non solo a Siena ma anche nel resto della Toscana.
Anche i Naibi (gli antenati delle carte moderne) erano molto diffusi e iniziarono a prendere piede all’incirca intorno alla prima metà del 1300, quando i reduci delle crociate iniziarono ad importare in Toscana questo passatempo, che presto divenne estremamente diffuso anche in città. Per valutare ancor meglio la portata di questo fenomeno si pensi che negli Statuti di Siena del 1262, per evitare sommosse, il gioco della Zara venne liberalizzato, designando Piazza del Campo come luogo pubblico adibito a tale attività. Il gioco rimase tuttavia proibito nelle osterie e in qualsiasi altro edificio chiuso, anche se gli stessi statuti senesi consentivano delle eccezioni. Ad esempio il giorno di Natale era possibile intrattenersi con qualsiasi tipo di gioco (non solo dadi ma anche carte) sia all’aperto che al chiuso anche nella propria abitazione. Da questa norma estremamente particolare nasce forse l’usanza, perpetuata fino ai giorni nostri, di giocare tra amici e parenti nello stesso periodo dell’anno tra panettoni, pandori e numeri della tombola.