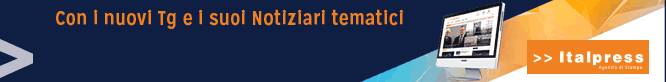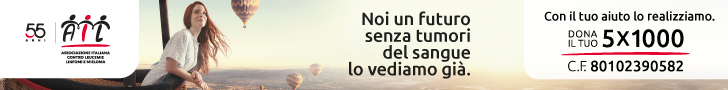“Sul cammino della Ninfa nella Città delle Acque e del Benessere” itinerario tra storia, etnografia, miti e realtà che porta alla luce luoghi e culture sconosciute

CHIANCIANO TERME. Un ruolo importante nello sviluppo di Chianciano Terme sono da sempre state le sue sorgenti d’acqua e ne sono i primi testimoni gli etruschi, che si insediarono in questo territorio già nel V secolo a.C., sede del culto di Apollo e a questo, in età ellenistica (III-II secolo a.C.), si affiancò quello di Diana-Sillene. Partendo dall’identità storico-etnografica di questa città termale l’Assessore alla Cultura di Chianciano Terme, Danila Piccinelli, nell’aderire al progetto promosso dalla Regione Toscana “Toscana. Ovunque Bella”, ha voluto concentrare l’insolita narrazione, un breve itinerario tra storia, etnografia, miti e realtà, avente come protagonisti due canopi etruschi, Tin e Thalna, improvvisamente riemersi dal terreno dopo 3000 anni, che si avventurano a scoprire “i segreti” del borgo di Chianciano Terme. “Tin e Thalna due canopi alla scoperta del borgo” è il titolo della storia su Chianciano Terme. I due canopi sono stati realizzati all’interno del Laboratorio di Restauro di Chianciano Terme da Giustino Frizzi e Giordano Masci. Le immagini sono state realizzate da Daniele Ciolfi e Patrizia Mari. Per leggere la storia visitare il sito: https://www.toscanaovunquebella.it/it?query=chianciano+terme&view=grid. 
La storia inizia con la notte della Super Luna (14 novembre 2016), quando la luna è definita “super magica” e si suppone accadono strani fenomeni. “La leggenda narra che Sillene, ninfa del Regno dei Morti, trovato un cammino nel buio della terra per risalire in questo mondo, si affacciò su un prato verde e, complice la luce della luna, vide un pastore che dormiva accanto alle sue pecore e se ne innamorò. Così di notte lasciava il regno dei morti e saliva sulla terra per guardare il suo pastore che dormiva. Se ne accorse Diana che punì la ninfa tramutandola in una sorgente che ancora oggi versa acque salutari a Chianciano Terme”. «Questo è l’incipit della storia di Tin e Thalna – afferma l’Assessore alla Cultura, Danila Piccinelli – un itinerario insolito per evidenziare alcuni aspetti della nostra storia e cultura poco noti al pubblico ma forse anche agli stessi chiancianesi, un modo per pensare di valorizzare ogni aspetto del patrimonio che abbiamo. Partendo proprio dal patrimonio materiale (Museo civico archeologico, Chiesa della Madonna della Rosa, Villa Simoneschi, la Madonna Nera di Chiesa Giubilei, ed altro) – prosegue Piccinelli – abbiamo dato cenno anche al patrimonio immateriale come il modo di parlare dei chiancianesi, costruendo un percorso che potrebbe rappresentare solo l’inizio di altre narrazioni che, partendo dalla storia reale, diventano contesti di conoscenza e di attualità, valorizzando cultura materiale ed immateriale come destinazione turistica». 
“Toscana. Ovunque Bella” è il nome del progetto che la Regione Toscana, supportato da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, che coinvolge in modo attivo tutti i Comuni e Anci Toscana. Il progetto esprime la volontà di comunicare e promuovere al meglio ogni territorio della Toscana, anche quelli meno conosciuti o meno visitati, valorizzandoli come altrettante destinazioni turistiche.
Toscana, Ovunque Bella, un progetto di crowd (sourced) storytelling, nato con l’ambizione di raccontare la nostra regione in modo nuovo e condiviso, promuovendo ogni giorno dell’anno uno dei 279 Comuni e tutti i Comuni per 365 giorni l’anno. Il progetto punta a dare risalto alle innumerevoli curiosità, alle storie irripetibili e inedite disseminate in tutta la Regione.
Cenni sugli Etruschi a Chianciano Terme
Chianciano Terme si trova al centro dell’Etruria settentrionale interna nella cui area sono state rinvenute testimonianze risalenti al Neolitico, insediamenti preistorici, testimonianze dell’età del Ferro e del successivo periodo orientalizzante, come quelle rinvenute in località Tolle, sviluppatasi fino al periodo longobardo. L’insediamento relativo dominava il valico della Foce, che mette in comunicazione la valle dell’Astrone con quella dell’Orcia, punto nodale della strada che collegava Chiusi col mare. Questa era controllata dall’insediamento, ancora da ubicare, riferibile alla necropoli della Pedata, la più ricca di tutto l’agro chiusino, scavata nel XIX secolo tra gli altri da A. François e recentemente rimessa in luce a Chianciano Terme. La ricchezza di questa necropoli, sviluppatasi tra l’inizio del VI e il III sec. a.C., in cui sono stati rinvenuti alcuni dei più significativi esemplari di scultura funeraria chiusina, quali la cosiddetta Mater Matuta e la statua-cinerario col defunto e Vanth, attesta la presenza in quest’area di ristretti gruppi aristocratici di notevoli possibilità economiche, confermata anche dall’esistenza di una produzione locale di vasi di bucchero. Come documentano le tombe a camera e a loculi disseminatevi, in età ellenistica anche questo territorio era costellato da piccoli insediamenti a carattere agricolo, come quello di Casa al Vento, presso La Foce, che era cinto da mura, e la fattoria di Poggio Bacherina, sviluppatasi nella seconda metà del II sec. a.C., in cui è documentata la lavorazione del vino. Altra fonte di ricchezza di questa zona era lo sfruttamento delle acque minerali e Chianciano costituisce ancora uno dei poli termali principali dopo la conquista romana con i famosi santuari localizzati presso “I Fucoli” e “Mezzomiglio” che sfruttavano le acque curative e che potrebbero essere i Fontes Clusini citati da Orazio.