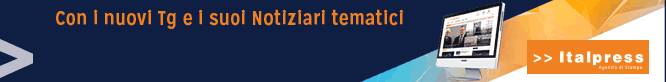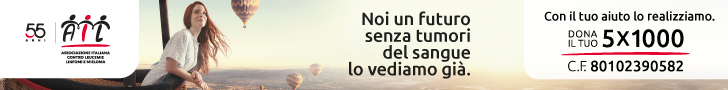di Fabrizio Pinzuti
AMIATA. La necessità della revisione della normativa vigente in tema di geotermia è più volte rimbalzata nelle agende di amministratori, politici e addetti ai lavori; in piena overcapacity – anche se non di overproduction – energetica certificata anche da Terna, distributrice dell’energia, e senza dunque che ci sia una impellente richiesta di energia, le nuove centrali geotermiche ricevono incentivi notevolmente superiori a quelle tradizionali – lo ha dichiarato anche Massimo Montemaggi, responsabile di Enel Green Power – senza che siano richieste loro garanzie di un’adeguata professionalità e “know how”, con un capitale sociale spesso irrisorio, senza alcuna fideiussione e garanzia, con un percorso concessorio facilitato e con la riduzione delle possibilità ostative da parte degli enti territoriali.
Unanime il riconoscimento che queste centrali sono redditizie per gli incentivi che ricevono, non per l’energia da loro prodotta, senza poi considerare il fenomeno della compravendita dei progetti, che spesso si nasconde nei frequenti cambi e passaggi societari, fenomeno denunciato dall’ex ministro dell’Ambiente – e quindi fonte autorevole – Alfonso Pecoraro Scanio a conferma delle speculazioni. A rendere attraente la geotermia elettrica sono stati e sono gli incentivi: sia quelli fino ad oggi previsti (tramite Certificati Verdi e Tariffa omnicomprensiva per gli impianti fino a 1 MW), che quelli attesi in base all’art. 24 del Dlgs n. 28/2011).
La corsa alla geotermia italiana nasce dal Decreto legislativo n. 22 dell’11/2/2010 (“Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche”), emesso in attuazione dell’art. 27 della L. n.99/2009. Tra le principali novità introdotte con questo decreto c’è stata l’eliminazione delle norme della L. n. 896/86 che attribuivano la preferenza a Enel e Eni per il rilascio dei permessi di ricerca e, in particolare, l’esclusiva delle attività di coltivazione delle risorse geotermiche a Enel nelle Provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. Il Decreto ha poi introdotto norme per consentire alle Regioni di regolare lo sfruttamento delle risorse geotermiche in base alla valutazione delle “possibili interferenze” tra nuove attività e attività già oggetto di concessione. La geotermia è uno dei pochi settori a essere stato favorito dal Decreto sulle rinnovabili elettriche, varato tra le polemiche nello scorso luglio 2016. Rispetto al vecchio sistema, che garantiva una remunerazione di circa 121 euro al Mwh per un impianto da 5 MW, il nuovo regime dovrebbe assicurare sussidi compresi tra i 99 e 172 euro a MWh, a seconda del tipo di installazione.
Sulla necessità di rivedere tali incentivi, concessi con troppa larghezza alla geotermia, e di armonizzare le ingiustificate differenze tra i cosiddetti “impianti pilota” e quelli ad autorizzazione regionale, utilizzanti la stessa tecnologia. Il D. Leg. 22/2010 ha trasformato il settore geotermico industriale da monopolistico a concorrenziale, aprendo il mercato ad una moltitudine di altri potenziali attori. La norma peraltro non prevede criteri di selezione dei soggetti abilitati a richiedere permessi di ricerca geotermica (es. esperienza settoriale specifica, requisiti strutturali, ecc.), dando titolo a chiunque lo richieda di ottenere un permesso, tanto che c’è chi parla non di liberalizzazione ma di deregulation.
Ad oggi esistono 108 permessi di ricerca sul territorio nazionale (di cui 51 sul territorio Toscano) che si sommano a 10 concessioni ministeriali per la realizzazione di centrali “pilota” (di cui 5 in Toscana) definite “sperimentali”, ovvero basate sulla tecnologia detta a “ciclo binario” che dovrebbe consentire la re-iniezione totale del fluido geotermico ed emissioni di gas in atmosfera nulle. Oltre che di massicci incentivi statali, di percorsi procedurali agevolati, questa tipologia di progetti – su cui finalmente sembra essere caduta l’attenzione del nuovo ministro del MISE Carlo Calenda – secondo quanto riferito in una nota del 9 maggio 2016 del Comitato Montecastelli Viva Onlus, gode anche di una speciale deroga all’applicazione della direttiva Seveso, concessa in base all’emendamento Abrignani confluito nel Decreto legge 69 del 9 agosto del 2013. Può essere utile qualche notizia sul proponente e sulla deroga.
Ignazio Abrignani è un deputato, oggi facente parte di Alleanza Liberaldemocratica Autonomie (ALA), guidata dall’ex coordinatore nazionale di Forza Italia e Pdl Denis Verdini, gruppo che ha più volte sostenuto Matteo Renzi; in passato Abrignani è stato a capo della segreteria politica dell’ex ministro Claudio Scajola e responsabile nazionale dell’Ufficio elettorale e organizzazione del Pdl.
La direttiva Seveso detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente ed è stata emanata in più riprese, dopo l’esplosione del 10 luglio 1976 all’interno di un reattore chimico dell’ICMESA, con la diffusione di una nube di diossina che investì la cittadina di Seveso in Lombardia, con effetti sulla popolazione e perfino sui bimbi ancora nel grembo materno, colpiti da una grave patologia, nota come “cloracne”. L’incidente ebbe ripercussioni di tipo sanitario sui lavoratori e sugli abitanti della zona esposti alla nube tossica, di tipo ambientale con la contaminazione del territorio adiacente, e di tipo psicologico per lo stato d’allarme indotto in tutta la popolazione. La scarsa conoscenza e la sottovalutazione dei rischi derivanti dalla presenza di insediamenti produttivi da una parte e la successiva crescente attenzione alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e alla qualità della vita degli individui dall’altra, posero la problematica del rischio industriale al centro del dibattito dell’opinione pubblica italiana ed europea. L’incidente di Seveso indusse i Paesi aderenti alla Comunità Europea a dotarsi di una normativa diretta a prevenire gli incidenti industriali.
E c’è chi esenta e chi è esentato dal rispetto di quella normativa.