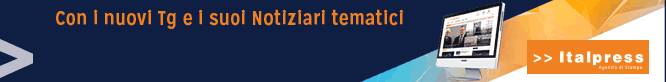di Fabrizio Pinzuti
AMIATA. Favorevoli e contrari alla geotermia sempre su opposte sponde e in mezzo la palude di chi non può, non sa o non vuole schierarsi, magari credendo, o facendo finta di credere, che la prudenza sia sempre e solo una virtù. Vien da chiedersi, ma la risposta non potrà mai essere esauriente, se dietro queste posizioni, oltre i tipi e le categorie umane ed eterne dell’individuo “in situazione” – che Umberto Eco ha riassunto nelle figure dell’integrato, del nevrotico e dell’innovatore – non ci sia anche un retaggio storico legato a fatti e vicende di questa terra.
Immediato il riferimento alla monoeconomia mineraria che ha caratterizzato e condizionato la vita della montagna almeno per un secolo e mezzo. Dalle schede presenti nel sito del museo minerario di Abbadia San Salvatore risulta che le proprietà iniziali e significative delle miniere dell’Amiata sono state tutte nelle mani di soggetti esterni. Di locale solo la mano d’opera o qualche impiegato con mansioni esecutive, senza neanche un tecnico “di concetto” e, tanto meno, di dirigenza. Tradotta in termini socio-economici l’attività estrattiva, non solo dopo le sue complete dismissioni, ha fatto e lasciato il vuoto dietro di sé e quanto è rimasto (villaggio minerario, ospedale, cinema), anche se spacciato come lungimirante opera di politica sociale, si è rivelato il frutto di volgari speculazioni, costituendo solo le briciole di un ben più lauto pasto consumato da “esterni”. Gli stipendi erogati – tra l’altro con la contropartita di tante morti sul lavoro, infortuni invalidanti e malattie professionali – rappresentano una nullità rispetto agli enormi profitti realizzati e investiti altrove. Dopo questa economia di sfruttamento e di depauperamento delle risorse è arrivato il periodo della cassa integrazione che se da un lato ha costituito un necessario ammortizzatore sociale, da un altro con il suo protrarsi ha contribuito a produrre fenomeni di disgregazione e all’istaurarsi di una cultura di assistenzialismo.
In questo contesto è stato facile per la geotermia presentarsi, se non come l’asso pigliatutto, come elemento cardine di sviluppo e di crescita all’interno dei vari progetti (Amiata, ENI, Regione Toscana) di riconversione dell’attività mineraria, rivelatisi fallimentari sotto il profilo economico e occupazionale, tranne che per i soliti abili a cogliere le occasioni. Le attuali preoccupanti vicende di Floramiata sono l’ultimo capitolo di questa storia. Andando a ritroso nel tempo si scopre però, al di là delle facili idealizzazioni del passato, talvolta in funzione polemica con il presente, al di là di un certo ottimismo di maniera e delle amenità che sempre emergono quando si parla della “propria” storia, che il binomio assoggettamento-sfruttamento in Amiata è inscindibile ed ha radici lontane. Forse non fu degli Etruschi, che ricavarono dall’Amiata materiali da costruzione e coloranti come il rosso cinabro, ma ai quali non si può attribuire lo stigma dello sfruttamento coloniale più bieco e spietato. Sicuramente fu dei Longobardi, dei Franchi, dei monaci dell’abbazia (vedi l’offerta dei ceri e dei censi), degli Aldobrandeschi, degli Orsini, del ducato di Orvieto, della repubblica di Siena, dei Medici e anche degli illuminati Lorena, che spogliarono l’abbazia dei suoi tesori, quali la Bibbia Amiatina e la Postilla, anche se testi e documenti storico-culturali di tal valore forse hanno trovato la collocazione a loro più consona nelle biblioteche Laurenziana e Nazionale, a disposizione degli studiosi e al riparo da furti e atti vandalici.
Si può insomma per brevità e sommariamente supporre che si sia creata con il tempo nell’Amiata quella particolare “forma mentis” dell’oppresso che accetta senza rendersene conto la sua posizione e che Stephan Bantu Biko, attivista sudafricano antiapartheid, ha definito “l’arma più potente nelle mani degli oppressori”. La complessità del fenomeno non può essere resa in una formula o in qualche riga ma, limitandosi alle grandi linee dell’assunto iniziale, si può postulare – in parallelo e in contrasto a questo – che si sia rafforzata la sfiducia nei lavori facili e nei “sùbiti guadagni”, tipica della gente dell’Amiata, abituata a lottare contro una terra dura ed avara ma a quella terra rimasta attaccata e nella quale oggi propone ed attua un modello di vita e di civiltà – e insieme di dignità del lavoro – che ha pochi eguali , pure nella formazione e gestione del paesaggio agrario e nell’antropizzazione del territorio, non solo riguardo alle attività agricole ma anche alle manifatture leggere a basso impatto ambientale, sulla base di un modello alternativo e incompatibile con quello industriale.
Le osmosi sociali non sono mai tuttavia a senso unico e non c’è da meravigliarsi se in questo periodo postindustriale e in questa terra che ha spesso lasciato ad altri deleghe deresponsabilizzanti continui la fiduciosa e anche ingenua attesa di una palingenesi dell’umanità attraverso la tecnologia, lo sviluppo, il progresso, attesa alimentata ad arte dagli immancabili fiutatori dell’affare che continuano a prosperare e a far sentire le loro pressioni su una politica non sempre attenta e all’altezza dei compiti a lei assegnati e talvolta in sospetto di connivenza.
Che strano! Ho sempre cercato di essere il più possibile laico, nel senso di non mettere la religione avanti a tutto, e mi trovo invece ad apprezzare e a condividere le posizioni di tanti cattolici, che hanno cercato di ridare voce e dignità ai tanti oppressi e derelitti, a cominciare da San Francesco, da David Lazzaretti, che pagò con la vita il suo disegno di riscossa sociale e morale, da altri preti scomodi come don Milani, don Mazzi, padre Ernesto Balducci, papa Francesco con la sua enciclica sulla cura “della casa comune”.