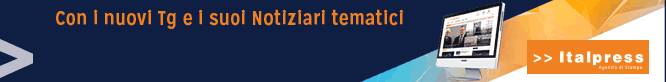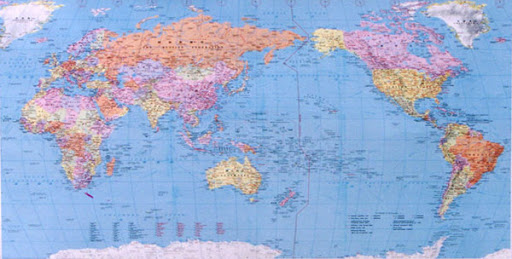
di Vito Zita
SIENA. (Seconda parte) I conflitti ai quali assistiamo sono caratterizzati da grande complessità e dalla sovrapposizione di diverse dinamiche, interne ed esterne, e un ruolo sempre più rilevante da parte di potenze emergenti a livello regionale. La crisi libica e quella siriana ne rappresentano un modello e l’attuale conflitto fra Armenia e Azerbaijan ne è una ulteriore conferma. Lo scoppio di conflitti militari, secessioni, tensioni a livello politico e sociale, hanno notevoli ricadute non solo sulla stabilità politico-istituzionale ma anche in ambito economico e finanziario. Si pensi alla crisi tra Ucraina e Russia, con le ricadute per il commercio e gli investimenti europei, alle tensioni politico-sociali a Hong Kong, che generano tensioni sui mercati, alle dispute nell’area del Golfo Persico, in una zona nevralgica per le relazioni commerciali globali o, infine, alle crisi libiche e siriane in cui la competizione è giocata da una pluralità di paesi, anche lontani, come la Russia.
Si può quindi adesso guardare come gli elementi esposti hanno inciso sull’evoluzione in ambito economico. Negli ultimi 20 anni il sistema internazionale ha subito profonde trasformazioni dal punto di vista economico e commerciale. A partire dalla Cina, si sono progressivamente affacciati sul panorama internazionale diversi Paesi con economie emergenti o in via di sviluppo (i BRICS, i Next Eleven, i Civets) che hanno contribuito a ridefinire le relazioni economico-commerciali e gli investimenti. Attualmente, le principali relazioni commerciali riguardano i Paesi emergenti o in via di sviluppo e sempre più investimenti economico-finanziari sono indirizzati verso di essi o da essi provengono.
È necessario quindi provvedere a gestire questo caos attraverso una nuova governance globale. Lo sviluppo infrastrutturale va spostandosi verso est e quindi, assieme alla ricchezza, anche il peso politico. La crescente rilevanza economica e politica dei cosiddetti Paesi emergenti ha influenzato le modalità attraverso le quali vengono concertate le strategie in ambito internazionale ed i relativi processi negoziali. Sebbene i Paesi occidentali ricoprano ancora una posizione di leadership, sempre più attori in varie aree del mondo contribuiscono a determinare le direttrici principali in ambito economico e finanziario. Lo sviluppo dell’Asia non è solo Cina e molto probabilmente nel prossimo futuro si parlerà di secolo asiatico. Una serie di trend mostrano un progressivo rallentamento dell’economia del dragone, misto ad un invecchiamento della popolazione. I capitali di investimento sono già pronti a deviare verso altri Paesi dell’area, verso il sud est asiatico e inoltre, fuori dalla Cina, nessuno vuole vivere in un secolo cinese. L’Asia tutta rappresenta il motore della crescita globale. Ma non sono solo luci. La Cina a sua volta è progressivamente diventata il principale motore dello sviluppo economico e del commercio a livello internazionale, ma ora va rallentando. Sebbene il tasso di crescita dell’economia cinese sia progressivamente diminuito, esso è ancora sostenuto ed è, in media, significativamente più elevato di quello statunitense. La Via della Seta voluta dal presidente cinese Xi Jinping è un progetto strategico elaborato dal presidente cinese nel 2013 volto a riposizionare la Cina sotto il profilo globale. Al centro del progetto c’è la realizzazione di una serie di corridoi terrestri e marittimi che attraverso l’Eurasia, garantiscano in collegamento per l’interscambio tra la Cina e l’Europa. La Cina mira a riconfigurare la propria industria verso produzioni ad alto contenuto tecnologico e quindi a sostituire gli USA nel ruolo di paese leader. E i numeri sono di assoluta rilevanza(fonte: Invesco SGR): 200 accordi di cooperazione siglati dalla Cina con altri Paesi; 600 rotte che collegano la Cina a 200 Paesi e 600 porti; 244.000 posti di lavoro creati grazie al Belt&Road; +41% l’incremento dei viaggi ferroviari dalla Cina verso l’Europa nel primo semestre 2020; 1,3 trilioni di dollari è il volume totale degli scambi tra la Cina e i paesi della Belt&Road. Con il lancio della Nuova Via della Seta cinese, l’Oceano Indiano si sta quindi sostituendo all’Atlantico in termini di centralità. Il mare fino ai primi anni del duemila era un dominio incontrastato della Marina degli Stati Uniti, tuttavia negli ultimi dieci anni qualcosa sta cambiando. La Cina è il più grande produttore al mondo di navi commerciali, è dotato dei più grandi porti al mondo e sta procedendo rapidamente ad un riarmo navale orientato a dotarsi di un apparato in grado di proteggere quelli che considerano propri mari e garantiti le proprie rotte. I mega porti cinesi rappresentano un asset strategico e lo si deduce dalla capacità dei principali porti cinesi. Nel 2018 (fonte: dati infoMARE) riportano che il flusso delle merci in transito in tutti i porti della Cina è stata pari a 239 mln di TEU (è la misura standard di volume nel trasporto dei container equivalenti a 33 m³, ovvero 21.600 kg.), con la sola Shangai capace di 42 mln di TEU. Tanto per tariffa un raffronto, Rotterdam l° porto europeo e 11° al mondo ha una capacità di 14,5 mln di TEU, Gioia Tauro, 1° porto italiano poco meno di 3 mln (assieme a Genova fa 6mln). La somma dei TEU dei quattro principali porti UE, Rotterdam, Anversa, Amburgo e Pireo, arriva malapena a 41,5 mln, quindi meno di Shangai. L’Oceano Indiano, rotta privilegiata della Via della Seta con i suoi passaggi obbligati, rappresenta lo spazio in cui la marina cinese misurerà le proprie aspirazioni oceaniche contrapponendosi alla US Navy per costruire un nuovo nome del nostro pianeta, alternativo a quello angloamericano.
Se mai vi sarà competizione militare diretta tra USA e Cina è probabile che avverrà in questo vasto spazio marino. La contesa per il Mar Meridionale Cinese, acque su cui insistono anche Filippine, Brunei, Malesia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Cambogia e Singapore, è la principale sfida per la Cina. La Cina sta infatti fortificando l’area con l’occupazione delle isole Spratly e Paracelso, atolli che vengono artificialmente allargati, creando basi navali e piste d’atterraggio per i propri caccia. Tale azione ha prodotto una linea di 9 tratti entro cui la Cina rivendica la propria sovranità.
Con queste premesse si può dire che siamo destinati alla guerra? Come tra Atene e Sparta, allo stesso modo la guerra tra USA e Cina è inevitabile? Guardando al modello cinese del passato, sembrerebbe di no. La Cina, pur essendo convinta di essere titolare di un ruolo speciale nel mondo e nella storia, non sembra seguire le orme dei secoli d’oro della Cina imperiale, quando si limitò a mettere in sicurezza i propri confini dai barbari con la Grande Muraglia e ottenere tributi dagli stati tributari come la Corea, in cambio del riconoscimento di uno status speciale e della concessione di benefici commerciali. La Cina si è insomma espansa in maniera soft, più per compenetrazione che per volontà colonizzatrice. Per la Cina quindi l’uso della forza militare è una risorsa estrema. Ciò nonostante essa intende le relazioni internazionali in maniera gerarchica e non egualitaria, infatti sono molti gli studiosi che vedono la cultura cinese come imperiale, etnocentrica e suprematista, almeno nei confronti dei popoli asiatici. Nonostante ciò la strategia cinese di diventare il perno del sistema economico-commerciale internazionale entro il 2049, anno in cui si celebrerà il centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, costituisce una sfida diretta alla storica leadership statunitense e crea numerosi impatti per la definizione delle regole di convivenza internazionale, ponendo alcuni attori, UE e suoi Paesi membri in primis, di fronte a scelte radicali.
Il quinto dominio è la competizione nel cyberspazio. Evocare la competizione sul cyberspazio porta immediatamente la mente sul tema hacker, furti dei dati, spionaggio elettronico, ma non è solo questo. La competizione è anche per conquistare i cuori e le menti degli utenti. I social media rappresentano l’altro grande terreno di scontro che vede competere Cina, Russia e USA. Il 5G renderà rivoluzionarie le nuove soluzioni di mobilità, rendendo le città intelligenti e consentendo alle aziende e alle persone di realizzare la piena promessa dell’Internet of Things (IoT). La Commissione europea (fonte: E.C., press release IP-19-1832) a gennaio 2020 stima, entro il 2025, un giro d’affari pari a 225 miliardi di euro con reti utilizzate da 2,6 miliardi di utenti nel mondo, pari al 40% del totale. La Cina guida saldamente la corsa internazionale al 5G, con il 34% dei brevetti riguardanti il 5G appartenenti a compagnie nazionali, in particolare Huawei e ZTE. La diffusione nell’utilizzo dei social network, rende così tali media spazio di competizione geopolitica e i grandi attori statali saranno presenti, non sempre in forma palese e con diversi obiettivi. Disinformazione e campagne di influenza si verificano sempre più spesso e le ultime elezioni USA e la crisi del Coronavirus sono esempi recenti. La competizione geopolitica del futuro verrà sempre più giocata su piattaforme multidimensionali in cui gli attori statali si impegneranno con tecniche di guerra ibrida in cui, sempre più spesso, il ricorso agli eserciti tradizionali sarà il rimedio estremo.