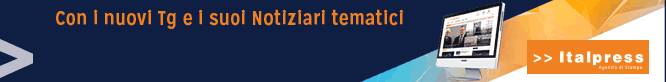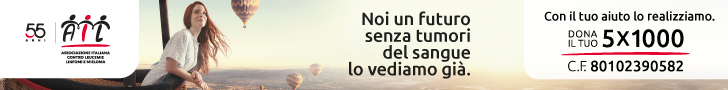Dal Brunello al Parmigiano: l’agricoltura d’oro del nostro paese può innescare speculazioni e altro

di Silvana Biasutti
MONTALCINO. Mentre la politica – “lejana y sola”, come direbbe il Poeta – si arrovella sui format da adottare per escludere i cittadini da qualsiasi leva decisoria, noi di campagna (ma anche di città) potremmo fare qualche considerazione su attività e prospettive e dare un po’ di numeri (e chiederne un po’ di più a chi ce li deve fornire) per capire più da vicino l’effetto che certe decisioni e certi sguardi avranno sul nostro futuro.
Mentre qui a Montalcino scorrono gli appuntamenti di Benvenuto Brunello, in un paesaggio produttivo dove anche i più tetragoni e meno vocati hanno capito fino in fondo che il legame autentico con la terra natale non si esprime solo a parole ma soprattutto con i fatti (con vantaggi di tutti e per tutti), questa mattina ho ascoltato una telefonata alla radio che mi ha lasciata perplessa.
Chi chiamava, lo faceva a proposito degli aspetti critici del recentissimo trattato commerciale CETA tra EU e Canada (che forse non tutela sufficientemente tutti i prodotti Made in Italy), auspicando che – per esempio – per fare il parmigiano reggiano, non si usino i foraggi locali, ma si vadano a cercare i foraggi delle zone che garantiscono un’impronta ecologica più lieve (e apparentemente più consona alle istanze dei consumatori orientati alla naturalità e al profilo ambientalistico dei consumi).
Mi è sembrata un’obiezione emblematica della complessità del tempo che viviamo, della confusione che viene indotta anche – a mio modo di vedere – per lasciare spazio alla speculazione dei grandi player globali.
 Perché mai si dovrebbe andare a prendere altrove (fuori da Parma e Reggio) il foraggio per nutrire le mucche che producono il latte per fare il parmigiano? Non si chiama forse parmigiano reggiano (o, altrimenti, lodigiano, o grana padano), in quanto prodotto con un latte che ha le caratteristiche peculiari di un terreno che produce una vegetazione peculiare, un foraggio che dà al formaggio certe caratteristiche? E non sono forse queste caratteristiche uniche all’origine del marchio? E non è forse questo marchio a dare un prezzo e un valore particolare (più altro) al parmigiano, rispetto a un altro formaggio simile ma non prodotto lì?
Perché mai si dovrebbe andare a prendere altrove (fuori da Parma e Reggio) il foraggio per nutrire le mucche che producono il latte per fare il parmigiano? Non si chiama forse parmigiano reggiano (o, altrimenti, lodigiano, o grana padano), in quanto prodotto con un latte che ha le caratteristiche peculiari di un terreno che produce una vegetazione peculiare, un foraggio che dà al formaggio certe caratteristiche? E non sono forse queste caratteristiche uniche all’origine del marchio? E non è forse questo marchio a dare un prezzo e un valore particolare (più altro) al parmigiano, rispetto a un altro formaggio simile ma non prodotto lì?
Penso che bisognerebbe stimolare ancora di più l’attenzione, la competenza e la cultura, a proposito di questi temi.
Anche il Brunello che conteneva una percentuale di altre uve insieme al Sangiovese grosso (come richiede la denominazione) forse nasceva da un buco culturale: dalla non comprensione del vero senso di una “denominazione”, che non è un fatto meramente verbale, è sostanza. E sapore, e qualità organolettiche, e unicità, talvolta rarità. Quindi prezzo che corrisponde a un valore reale – intrinseco – e non a fatti speculativi o di nomenclatura.
 Non sono osservazioni marginali, perché oggi – leggendo alcuni giornali – ho preso nota di un po’ di numeri che danno un’idea della centralità del cibo, delle attività per crearlo (incluso l’import), dei posti di lavoro indispensabili per produrre qualità (proprio come per un abito di alta sartoria), dei rischi che il consumatore corre se, credendo di mangiare una scodella di lenticchie “di Castelluccio”, invece si sta nutrendo con una scodella di lenticchie “confezionate” a Castelluccio, ma nate e cresciute in Turchia o in Canada, in condizioni colturali impossibili da controllare, ma pagate (le lenticchie) come se fossero un sublime prodotto della pregiatissima agricoltura di nicchia italiana. Con l’esclusivo vantaggio per il fatturato del supermercato che le vende, e tutti i costi e i rischi, o i dubbi, per la salute del consumatore o come minimo, per il suo portafoglio.
Non sono osservazioni marginali, perché oggi – leggendo alcuni giornali – ho preso nota di un po’ di numeri che danno un’idea della centralità del cibo, delle attività per crearlo (incluso l’import), dei posti di lavoro indispensabili per produrre qualità (proprio come per un abito di alta sartoria), dei rischi che il consumatore corre se, credendo di mangiare una scodella di lenticchie “di Castelluccio”, invece si sta nutrendo con una scodella di lenticchie “confezionate” a Castelluccio, ma nate e cresciute in Turchia o in Canada, in condizioni colturali impossibili da controllare, ma pagate (le lenticchie) come se fossero un sublime prodotto della pregiatissima agricoltura di nicchia italiana. Con l’esclusivo vantaggio per il fatturato del supermercato che le vende, e tutti i costi e i rischi, o i dubbi, per la salute del consumatore o come minimo, per il suo portafoglio.
Ecco perché ho trovato interessante apprendere che sta partendo la legge sull’agricoltura biologica, un comparto della cui crescita ci siamo tutti accorti; magari con qualche perplessità sulla dicitura “bio” che qualche volta appare più che altro un modo per attrarre, e qualche altra volta appare una bufala. Ma ci penseranno (si spera) i controlli.
Infatti nel 2016 con stati comminati due milioni di euro di sanzioni per prodotti contraffatti; mentre per lo sviluppo del comparto bio, il governo investirà un miliardo e mezzo.
E leggendo scopro anche che, nel nostro paese, ci sono 600mila imprese condotte da giovani sotto i 35 anni: di queste, 52mila sono imprese agricole (oltre il 12%), testimoniando con questi numeri la reale riscoperta dell’agricoltura, da parte dei giovani. Magari sulla scia del nuovo interesse per il biologico e le tecnologie legate alla naturalità?
 Poi però, magari mi pongo altre domande sul futuro del cibo, se apprendo che i prezzi, che sono stati pagati ai coltivatori di grano duro, non coprono i costi di produzione. Questa dura realtà ha fatto sì che ci sia stata una contrazione di oltre il 7% delle superfici destinate a tali colture. Questo numero avrà conseguenze pesanti sulla produzione della pasta italiana, che si servirà ancora di più di grano duro proveniente dall’estero; magari da paesi dove all’insolazione meno idonea si sopperisce con l’uso di diserbanti o di altre diavolerie chimiche. E siccome sull’etichetta della pasta non si è ancora arrivati a scrivere da dove proviene il grano, magari la pasta made in Italy viene dal paese con cui la EU ha appena firmato trattati commerciali di cui sappiamo ancora troppo poco: per esempio il Canada, che è anche il paese che produce buona parte del grano duro con cui viene prodotta la pasta di alta qualità made in Italy.
Poi però, magari mi pongo altre domande sul futuro del cibo, se apprendo che i prezzi, che sono stati pagati ai coltivatori di grano duro, non coprono i costi di produzione. Questa dura realtà ha fatto sì che ci sia stata una contrazione di oltre il 7% delle superfici destinate a tali colture. Questo numero avrà conseguenze pesanti sulla produzione della pasta italiana, che si servirà ancora di più di grano duro proveniente dall’estero; magari da paesi dove all’insolazione meno idonea si sopperisce con l’uso di diserbanti o di altre diavolerie chimiche. E siccome sull’etichetta della pasta non si è ancora arrivati a scrivere da dove proviene il grano, magari la pasta made in Italy viene dal paese con cui la EU ha appena firmato trattati commerciali di cui sappiamo ancora troppo poco: per esempio il Canada, che è anche il paese che produce buona parte del grano duro con cui viene prodotta la pasta di alta qualità made in Italy.
Ma diamo i numeri?