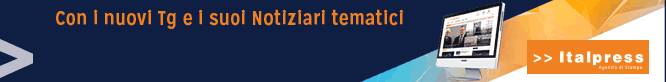Il volume è stato presentato nella biblioteca degli Intronati
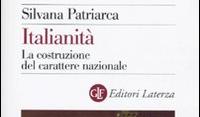
SIENA. Sono passati 150 anni di storia nazionale, nel corso dei quali alcuni avvenimenti hanno sicuramente cementato il senso di appartenenza al Paese, come le lotte operaie e contadine della fine dell’Ottocento, i due conflitti mondiali, la dittatura fascista e la Resistenza, la lotta contro il terrorismo degli anni ’70, il contrasto alla mafia e la corruzione politica a partire dagli anni Novanta, ma siamo e ci vedono, ancora, divisi sotto il tricolore.
Silvana Patriarca con il suo Italianità. La costruzione del carattere nazionale (Editori Laterza), presentato ieri pomeriggio, nel Salone storico della Biblioteca comunale degli Intronati per la rassegna Lunedilibri dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia ripercorre, da attenta studiosa (è docente di Storia europea contemporanea alla Fordham University di New York), la genesi di un senso di cittadinanza per il quale, oggi, è richiesto molto più delle origini dei natali o della residenza anagrafica.
Il carattere nazionale e l’identità, infatti, non solo rappresentano un elemento cardine nella volontà politica che ha permesso l’unità, ma, anche, le riflessioni che, da allora a oggi, hanno interessato gli ambienti intellettuali a vario titolo coinvolti nei momenti salienti della nostra storia. Dal Risorgimento alla Grande Guerra, dal fascismo al secondo conflitto mondiale, alla Resistenza. Non meno nel periodo più recente, quello che ha visto la ricostruzione di un’economia e di una società uscita dal mito perdente, dove sul nazionalismo si era voluto creare un impero per il quale, però, non era nato il “nuovo italiano” auspicato da Mussolini. Siamo troppo disgregati, troppo individualisti, troppo succubi di quel familismo oramai riconosciutoci da tutti e mascherato da quella frase sempre più vuota: “italiani brava gente”.
“Il libro della Patriarca è complesso – come giustamente ha osservato l’assessore alla cultura Marcello Flores d’Arcais – ma, anche, estremamente interessante perché attraverso l’analisi dei testi politici vengono presi in considerazione i vizi degli italiani, come l’ozio e la passività gli stessi che saltavano agli occhi degli stranieri di un secolo e mezzo fa e dei contemporanei agli occhi dei quali sembriamo una copia lontana, e venuta niente bene, a confronto di chi aveva creato l’impero romano. Ma se nel termine “carattere” rientrano le caratteristiche morali e psicologiche e nella parola “identità”, nata dopo, si riconosce il senso di appartenenza di un individuo ad un territorio, allo stesso tempo il carattere, strettamente soggettivo, non si può applicare ad un’intera collettività”. Ma dato che il tema dell’argomento affrontato è il carattere, quello che i patrioti del Risorgimento volevano cambiare per costruire l’Italia unita, lo stesso che il fascismo voleva plasmare, lo stesso elementarmente costruito dagli stereotipi che ci contraddistinguono, questo carattere è cambiato o è rimasto lo stesso? Lo stesso raccontato dai film interpretati da Alberto Sordi, da Totò o dal più recente Verdone?.
“Mi rifiuto di pensare che non sia cambiato niente – ha detto la Patriarca – la storia ha innescato un cambiamento nella società”. Un’evoluzione che ci porta a guardare oltre i banali stereotipi. “Difficile distruggere gli stereotipi, ma la storicizzazione delle “immagini” è importante per comprendere i mutamenti”.
“La nostra recente Repubblica italiana – ha evidenziato Flores – non ha applicato una forte idea pedagogica per costruire l’italiano, è una mancanza?”
“Per far crescere il concetto di cittadinanza – ha risposto la sua collega – occorre uno sforzo da parte dello Stato”, ma, nonostante questa affermazione, la Patriarca non vuole parlare di antiitalianità. “Troppo facile considerare la storia nazionale carica di “assenze”: non siamo capaci di…, meglio leggerla con tutte le sue “presenze””.
Sicuramente la strada giusta, questa, per affrontare un concetto allargato di identità. Quello richiesto da un mondo ed un vivere sempre più globalizzato, dove i localismi diventano stretti da abitare.
Meglio, allora, come ha concluso la studiosa, abbandonare i concetti stereotipati e parlare degli italiani come di una società in cambiamento.